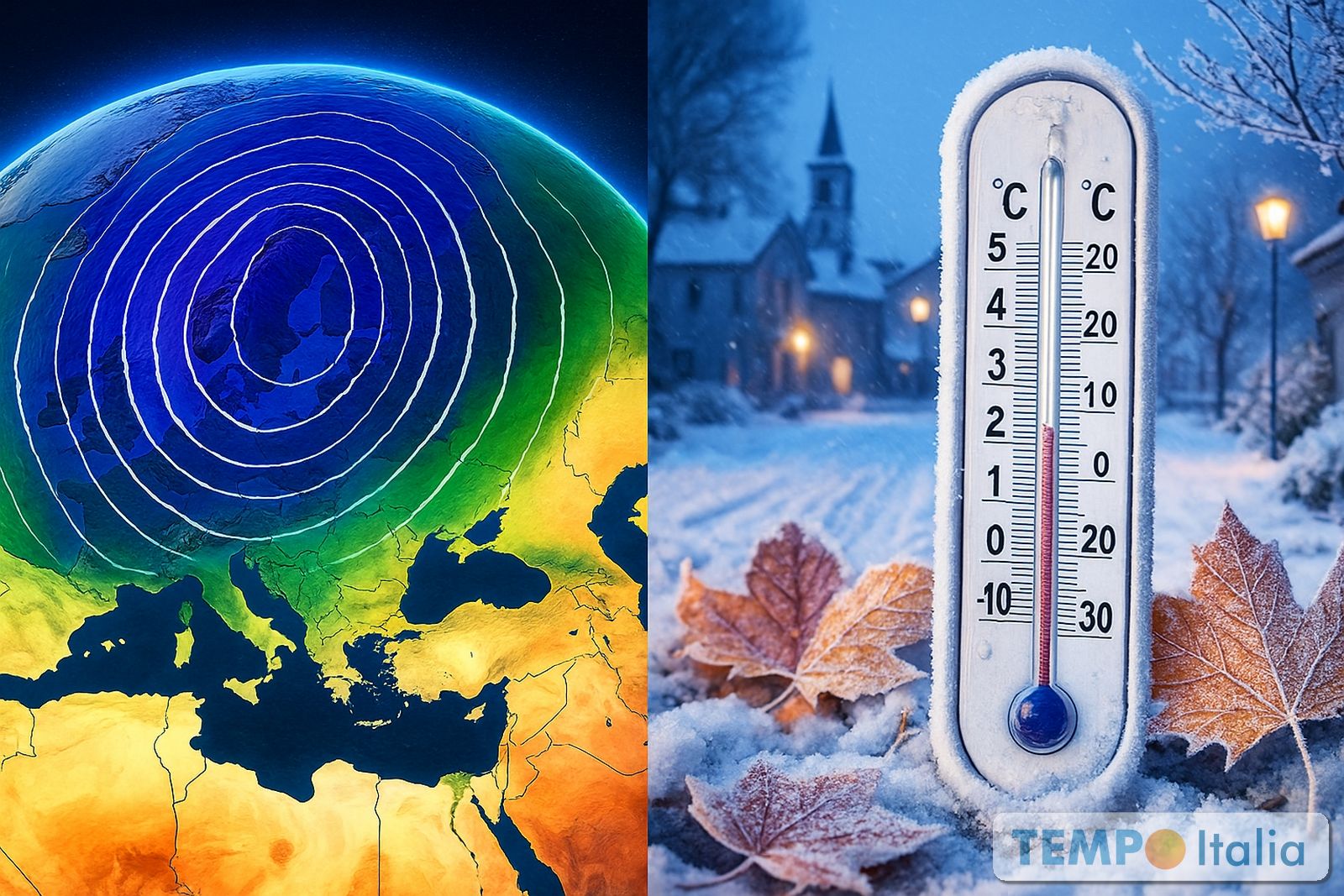
(TEMPOITALIA.IT) Nelle ultime giornate l’aria ha iniziato a raffreddarsi con decisione sopra il Mar Glaciale Artico. Il calo termico ha coinvolto la Stratosfera e i livelli più bassi dell’atmosfera, favorendo la formazione del primo nucleo freddo che costituirà il nuovo Vortice Polare invernale. Fin qui, nulla di inatteso per la stagione. Eppure le mappe mostrano un dettaglio cruciale: il sistema non appare compatto come potrebbe, e alcuni segnali dinamici in quota lasciano intendere un possibile cambio di scenario.
Quando si parla di Vortice Polare si immagina spesso una struttura monolitica, un enorme mulinello capace di trattenere il freddo nelle alte latitudini. In realtà è un organismo in continua evoluzione, sensibile a ciò che accade sia in superficie sia in quota. Talvolta basta un blocco anticiclonico tra Groenlandia e Canada o un’ondulazione del Jet Stream per modificarne ritmo e forma. È quello che, osservando i principali modelli, potrebbe profilarsi tra la fine di Novembre e i primi giorni di Dicembre.
La domanda naturale è una sola: quanto conta davvero un Vortice meno intenso per il tempo sull’Europa e sul Mediterraneo centrale La risposta non è immediata, perché i passaggi tra Stratosfera e Troposfera richiedono giorni e non avvengono sempre con la stessa efficacia. Ma un Vortice più debole aumenta la probabilità che porzioni di aria artica scivolino verso sud, aprendo finestre per fasi fredde e periodi di maltempo alle medie latitudini.
Cos’è il Vortice Polare e perché si rafforza in inverno
Il Vortice Polare è una vasta circolazione ciclonica che si sviluppa nella Stratosfera sopra il Polo Nord durante la stagione fredda. Nasce perché l’assenza di luce solare polare favorisce un forte raffreddamento dell’aria, che diventa densa e crea un minimo di pressione in quota. Attorno a questo minimo si organizzano intensi venti da ovest. Quando i venti corrono tesi e regolari, il Vortice è forte e trattiene l’aria gelida vicino all’Artico. Se invece rallentano o si deformano, la struttura perde coesione e il freddo può propagarsi verso le medie latitudini.
Per visualizzarlo, si può pensare a una cintura che avvolge il freddo. Se la cintura è ben serrata, il contenuto resta al suo posto. Se la cintura si allenta, una parte dell’aria fredda trova varchi e traccia discese verso sud. A fare la differenza sono le onde planetarie, grandi ondulazioni atmosferiche che partono dalla Troposfera e risalgono verso la Stratosfera, dove depositano energia frenando i venti zonali.
Perché ora potrebbe indebolirsi: il ruolo dei blocchi e delle onde
Nelle prossime settimane i modelli intravedono la possibilità di blocchi anticiclonici tra Groenlandia e Canada e un aumento dell’attività ondulatoria del Jet Stream. Queste forzanti, note come onde di Rossby, sono in grado di trasferire energia verso l’alto. Quando l’energia d’onda raggiunge i livelli stratosferici intorno ai 30 chilometri di quota, i venti da ovest che ruotano attorno al Polo possono rallentare. Se il rallentamento diventa consistente e persistente, il Vortice si deforma o si sposta. Nei casi più estremi può subire un Stratwarming con riscaldamento rapido in quota e forte indebolimento della circolazione.
È importante non confondere un indebolimento con un collasso. La stagione è nella fase in cui il Vortice tende fisiologicamente a rafforzarsi, perché la Stratosfera polare continua a raffreddarsi tra Novembre e Dicembre. Per questo motivo, i segnali di disturbo vanno letti come finestre di vulnerabilità, non come una sentenza definitiva. Se l’attività d’onda dovesse ridursi, il Vortice tornerebbe rapidamente su binari più stabili.
Cosa succede se il vortice si indebolisce
Quando i venti a circa 10 hPa rallentano, la circolazione perde simmetria e la massa d’aria fredda può essere spinta verso latitudini inferiori. La risposta al suolo non è istantanea. Spesso trascorrono da una a tre settimane prima che i segnali stratosferici si traducano in cambiamenti nella Troposfera. Il risultato più comune non è necessariamente il gelo diffuso, ma una maggiore probabilità di irruzioni fredde, di fasi perturbate e di contrasti termici più marcati lungo le linee frontali.
In Europa, gli esiti dipendono dall’asse della deformazione del Vortice. Se la spinta ondulatoria privilegia l’Atlantico nord occidentale, aumenta la probabilità di blocchi su Groenlandia con correnti da nord e nordest verso l’Europa centro settentrionale. Se invece la spinta si concentra sul comparto pacifico, la risposta europea può essere più attenuata o differita. È uno dei motivi per cui le previsioni su scala regionale rimangono aperte fino a ridosso degli eventi.
Europa e Italia: scenari possibili tra fine novembre e inizio dicembre
Considerando lo stato stagionale, un Vortice meno teso tra fine Novembre e avvio di Dicembre favorirebbe finestre per episodi più freddi sul settore europeo settentrionale e centrale. Per il Mediterraneo e l’Italia lo scenario resta condizionato dal posizionamento dei blocchi e dal tracciato delle saccature. Se i massimi di pressione si consolidassero tra Groenlandia e Islanda, i flussi potrebbero piegare verso sud e sudest, con aria più fredda in ingresso dall’Artico continentale. In alternativa, un blocco più arretrato o una risposta troposferica debole lascerebbero spazio a correnti atlantiche umide e miti, con piogge ma senza freddo incisivo.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la modulazione locale. Il Nord Italia è sensibile alle inversioni termiche, alle nebbie e all’effetto barriera alpino, fattori che possono attenuare o amplificare gli sbalzi termici. Il Centro Sud e le Isole Maggiori rispondono più rapidamente alle variazioni di massa d’aria, specie lungo i versanti esposti alle correnti. In presenza di mari ancora relativamente miti, i contrasti con l’aria più fredda in quota possono esaltare rovesci e temporali, soprattutto sulle aree tirreniche.
Gli indicatori da tenere d’occhio
Prevedere la catena di eventi tra Stratosfera e Troposfera significa tenere d’occhio alcuni indicatori. Il primo è l’andamento del vento medio zonale a 10 hPa e 60 gradi nord, utile per misurare la tensione del Vortice. Un suo calo prolungato è un campanello d’allarme per la coesione della struttura. Il secondo è la propagazione del segnale verso il basso, che si valuta attraverso indici come l’Arctic Oscillation e le anomalie di geopotenziale a quote troposferiche. Il terzo è la persistenza dei blocchi, in particolare la tenuta delle alte pressioni sulla Groenlandia e sull’Atlantico nord.
A scala previsionale, la finestra di affidabilità piena per la Stratosfera si estende circa dieci giorni, oltre i quali entrano in gioco le probabilità fornite dagli ensemble. Per la Troposfera, l’incertezza cresce più rapidamente, soprattutto quando la circolazione è dominata da onde ampie e blocchi. Questo significa che le tendenze sono utili per inquadrare il contesto, ma le traiettorie dei minimi e la distribuzione dei fenomeni richiedono aggiornamenti ravvicinati.
Cosa non promette questo segnale
Un Vortice meno intenso non implica automaticamente freddo imminente e generalizzato. È un fattore che aumenta le chance di irruzioni fredde, ma i dettagli dipendono dall’allineamento di più tasselli. Allo stesso modo, un episodio di freddo non dimostra di per sé un cambio di regime stagionale. La stagione invernale è fatta di alternanze e la Stratosfera fornisce il contesto di fondo su cui agiscono i sistemi di Atlantico e Mediterraneo. Evitare scorciatoie interpretative è parte del rigore necessario quando si raccontano processi complessi che collegano quote e tempi diversi.
Credit: ECMWF Sub seasonal range forecast, mean zonal wind 10 hPa, NOAA CPC Stratospheric analyses and forecasts, Met Office learning hub, Polar Vortex, Copernicus WCD, troposphere stratosphere coupling, University of Oklahoma GEFS stratosphere dashboard (TEMPOITALIA.IT)
Vortice Polare in bilico: segnali di indebolimento, le ripercussioni in Europa e Italia