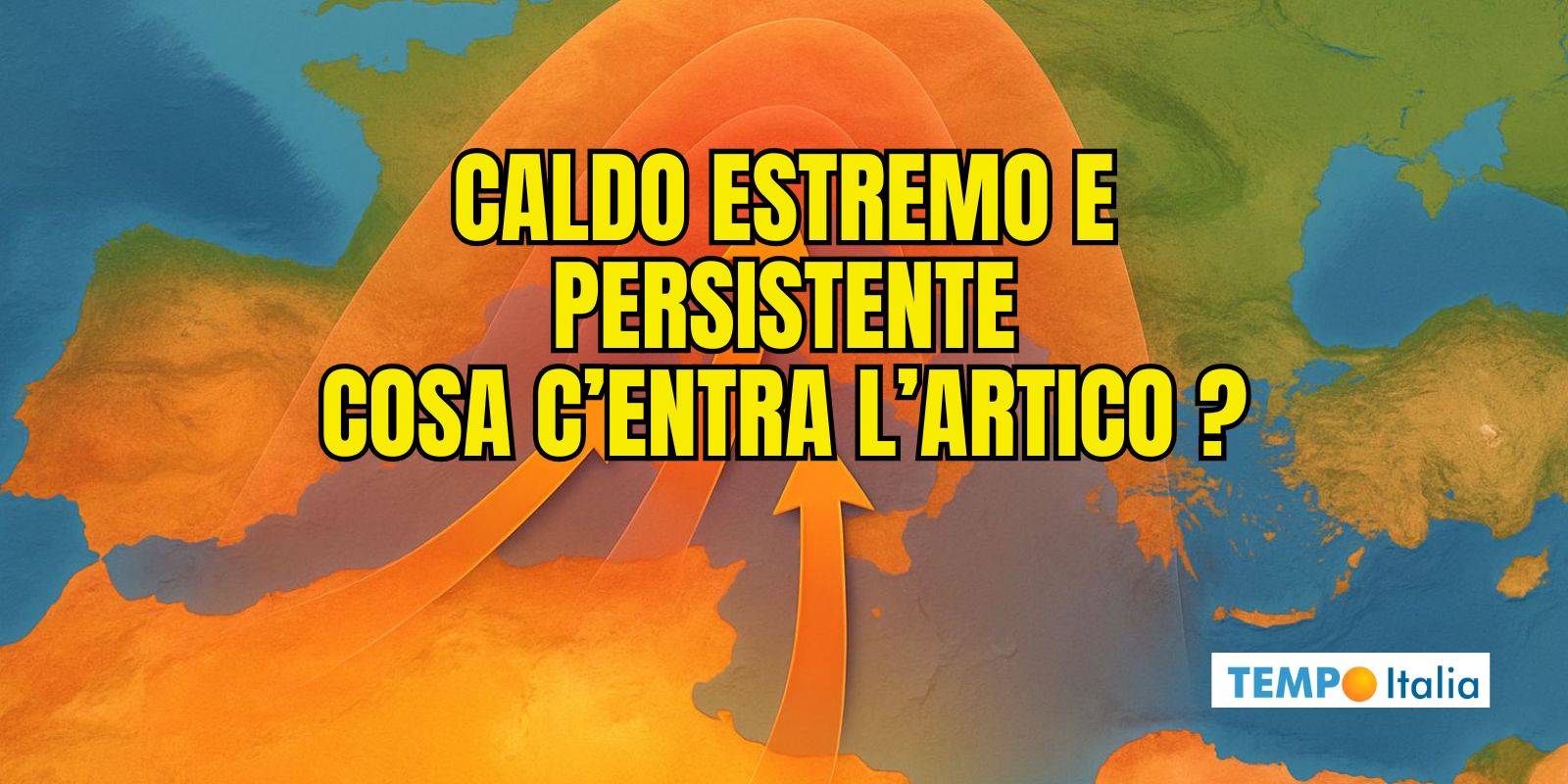
Nel panorama sempre più complesso del cambiamento climatico, uno dei legami più discussi e al tempo stesso meno compresi dal grande pubblico è quello tra la diminuzione del ghiaccio marino artico e l’aumento delle ondate di calore persistenti nelle medie latitudini, come quelle che interessano l’Italia e il bacino del Mediterraneo. Un nesso che, secondo una parte crescente della comunità scientifica, potrebbe essere cruciale per spiegare perché le alte pressioni africane si mostrino sempre più stabili e durature durante l’estate.
Un Artico che si sta scaldando troppo in fretta
Negli ultimi trent’anni, l’Artico si è riscaldato a un ritmo almeno doppio rispetto al resto del pianeta, un fenomeno conosciuto come amplificazione artica. L’effetto più evidente è la drastica riduzione della copertura di ghiaccio marino, soprattutto nei mesi estivi. A SETTEMBRE, che rappresenta il punto minimo annuale dell’estensione del ghiaccio, si registrano ormai valori inferiori del 40% rispetto agli anni Ottanta.
Ma perché ciò che accade al Polo Nord dovrebbe interessare l’estate italiana? La risposta sta nell’equilibrio dinamico dell’atmosfera.
Il ruolo della corrente a getto e la sua crescente instabilità
La corrente a getto polare, quel fiume d’aria che scorre da ovest verso est ad alta quota, delimita la massa d’aria fredda artica da quella più calda delle latitudini inferiori. Quando il contrasto termico tra Polo e fascia temperata è netto, questa corrente si presenta tesa e regolare. Ma con l’Artico più caldo, la differenza di temperatura si riduce e il getto si indebolisce, assumendo un andamento più ondulato e irregolare.
Questa ondulazione favorisce la formazione di blocchi atmosferici, cioè strutture di alta pressione che si posizionano in un’area e vi rimangono per giorni o settimane. Se una di queste onde si stanzia sul bacino del Mediterraneo, come accade sempre più spesso, si innescano lunghi periodi di stabilità atmosferica, associati a caldo estremo, siccità e formazione delle heat dome, ma anche ad eventi temporaleschi esplosivi quando l’equilibrio si rompe.
Mediterraneo e anticicloni: il legame con il Polo Nord
Nel caso specifico dell’Italia, la persistenza di anticicloni subtropicali, spesso di matrice africana, si è fatta più marcata proprio in corrispondenza degli anni in cui la perdita di ghiaccio artico è stata più significativa. Gli studi più recenti suggeriscono che esiste un feedback climatico tra la perdita di riflettività del ghiaccio (albedo) e l’alterazione dei pattern di circolazione atmosferica estiva.
In particolare, la riduzione del ghiaccio nel Mar Glaciale Artico, a ridosso delle coste della Siberia e del Canada artico, sembra influenzare le ondulazioni più meridionali della corrente a getto, favorendo il rafforzamento di cupole anticicloniche sul Centro-Sud Europa. Questo fenomeno porta con sé periodi eccezionalmente caldi che si autoalimentano, perché il suolo surriscaldato riduce ulteriormente l’umidità e aumenta la resistenza all’instabilità.
L’Italia come cartina di tornasole climatica
L’Italia, per la sua posizione di cerniera tra clima temperato e clima subtropicale, è diventata una zona particolarmente sensibile a questi squilibri. Le estati mediterranee, un tempo intervallate da pause fresche, sono oggi dominate da fasi stabili e opprimenti, spesso interrotte solo da fenomeni violenti. Questo non è più un’anomalia, ma un nuovo regime climatico in via di consolidamento.
Alcuni ricercatori del National Center for Atmospheric Research e del Met Office hanno messo in luce una correlazione crescente tra le estati artiche eccezionalmente calde e l’anomalo comportamento delle onde planetarie nell’emisfero nord. Secondo questi studi, i picchi di calore in Europa meridionale potrebbero essere solo un effetto collaterale visibile di un disequilibrio atmosferico più profondo.
Un legame da monitorare con attenzione crescente
La meteorologia del futuro non potrà più ignorare il legame tra ghiaccio artico e clima mediterraneo. Questo asse polare-temperato è oggi uno degli ambiti di ricerca più attivi, con l’obiettivo di comprendere come prevenire o almeno mitigare gli effetti delle ondate di calore prolungate, che in Italia minacciano non solo la salute umana, ma anche l’agricoltura, le risorse idriche e la tenuta delle infrastrutture.
Meteo: sempre più caldo? Il vero responsabile che non ti aspetti